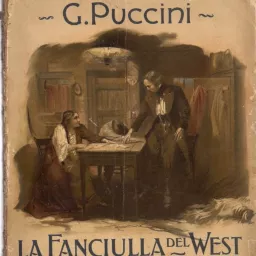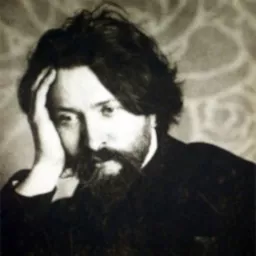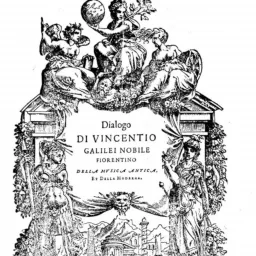Ferruccio Busoni. Cultore del passato
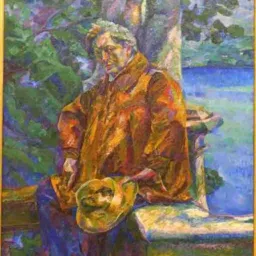
Si intitola Cultore del passato, divinatore dell’avvenire. Un ritratto di Ferruccio Busoni questo ciclo, realizzato da Francesco Dilaghi nel 2016 per il 150esimo anniversario della nascita del compositore empolese, che trasmettiamo nuovamente del centenario della morte. Ferruccio Busoni fu un musicista e un intellettuale di prima grandezza nel panorama pur ricchissimo della cultura europea a cavallo tra Otto e Novecento. Eppure la sua figura ha sempre affascinato e conquistato i musicisti e i musicologi più del grande pubblico dei concerti e dei dischi: infatti, a distanza ormai di un secolo dalla scomparsa, è ancor vero che sono poche le sue composizioni – con l’eccezione solo delle trascrizioni pianistiche da musiche di Bach – che sono riuscite a entrare stabilmente nel repertorio dei concerti. Non è fra queste, per esempio, la pur splendida Berceuse élégiaque per orchestra, e neanche il suo capolavoro teatrale della piena maturità, Doktor Faust. Le ragioni di questa sorta di “disaffezione” da parte del pubblico sono da ricercare in gran parte nella complessità della sua figura e del suo linguaggio, impossibile da inserire in nessuna categoria e in nessun “ismo”: complessità che si manifesta e si spiega con i molti elementi contraddittori, a cominciare dalla sua stessa identità nazionale, divisa tra Italia e Germania. Contraddittoria è la sua spiccata originalità di linguaggio rispetto alla sua profonda e completa conoscenza e padronanza di tutto il mondo musicale del suo tempo; così come contraddittoria è la sua stessa identità di artista, divisa tra l’attività di sommo virtuoso di pianoforte, fecondo compositore per i più disparati generi e organici, e acutissimo indagatore delle più profonde ragioni dell’esperienza musicale fino all’indagine sullo stesso primario elemento del suono. E anche il titolo scelto per questo ciclo vuole mettere in evidenza un ulteriore elemento di contraddizione, cioè una visione dell’arte musicale che ha da un lato profondissime radici e motivazioni nell’eredità del passato (e in termini del tutto privilegiati con la somma lezione di J.S. Bach), ma dall’altro riesce a spingersi con lucidità nei più audaci – o anche solo possibili e virtuali – sentieri della modernità. Una figura dunque di artista e intellettuale a 360 gradi, che merita sempre (e ancor più oggi, dove ogni esperienza musicale sembra per forza doversi consumare obbligatoriamente in modo semplice, immediato e divertente) di essere indagato e interrogato. Un compositore del quale meritano di essere ascoltate le composizioni, ma che merita di essere anche scoperto nei suoi scritti, sempre profondi e illuminanti, che restano la miglior chiave di lettura per capire le vere ragioni della sua musica: una musica che può senza dubbio risultare per il pubblico non facile, e anzi spesso problematica, ma che si rivelerà sempre ricca di significati e di valori mai affidati alla “superficie”, all’evidenza di un primo e generico ascolto.